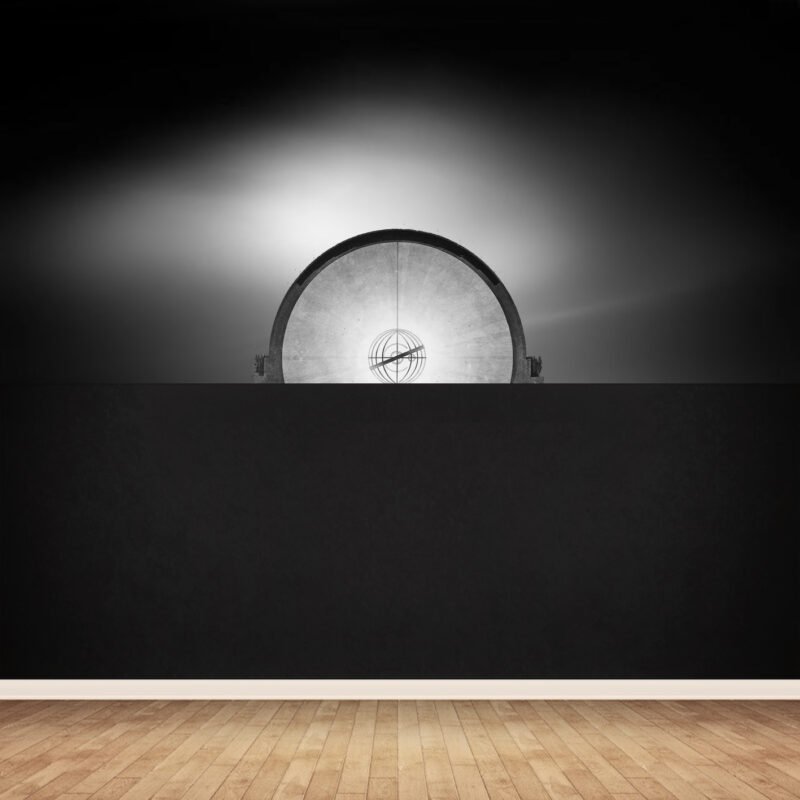La verità giudiziaria e i suoi nemici

di Roberto Oliveri del Castillo
Scrittore e magistrato
“L’osservatore non può essere separato da ciò che osserva.” (W.K. Heisenberg)
- Ricerca della verità e verità del ricercatore.
La domanda su cosa sia la verità è antica quanto l’uomo e ne troviamo una traccia nel resoconto del processo forse più noto ed importante della Storia, quello a Gesù, riportato nel Vangelo di Giovanni (18.38) allorquando, come è noto, Gesù Cristo risponde a Pilato che lui è venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Al chè il Procuratore della Giudea, con una chiara manifestazione della sua cultura laica e scettica, enuncia la famosa frase “Quid est veritas?” lasciata senza risposta, ma accompagnata col gesto, in sé eloquente, di comunicare alla folla sotto il Pretorio che “Ego nullam invenio in eo culpa causam”.
Da allora il dibattito filosofico sulla verità è proseguito, con risultati che, a distanza di oltre duemila anni, forse conferiscono conferma all’intuizione sotto forma di domanda di Pilato, sulla impossibilità di fornire una risposta chiara che non sia solo enunciativa.
Se una accreditata definizione del concetto di verità la descrive come “il discorso che dice le cose come stanno” (Platone, Cratilo: cfr. F. D’Agostini, M. Ferrera, La verità al potere, Einaudi, 2019), è facile rilevare che tale definizione definisce i contorni di un aspetto particolare della tematica filosofica afferente la verità, ovvero quello cd. “ontologico” o assoluto, mentre non esaurisce i più problematici aspetti dell’ambito cd. “gnoseologico”, ovvero quello afferente la conoscenza umana, rispetto al quale la ricerca di criteri di evidenza (sensibile, intellettiva, induttiva o deduttiva) per giungere alla verità in un certo campo, appare molto più problematica e relativistica, e pertanto da ancorare più che a concetti, a modalità date e condivise di ricerca.
Se partiamo dal termine in uso presso gli antichi greci, aletheia, ovvero ciò che viene dis-velato, scoperto, e che appare quindi nudo nella sua essenza, si comprende bene come il giungere alla verità sia lo svolgimento di un iter, di un percorso procedimentale che deve essere connotato di corrispondenza ad un metodo ermeneutico che faccia giungere da ciò che è ignoto a ciò che diventa acclarato, attraverso un procedimento ricostruttivo che risponda a determinati standards prestabiliti da un sistema normativo.
Ciò su cui appare utile riflettere, è se nel sapere umano sia possibile giungere alla “Verità assoluta”, e giungere quindi ad una “Conoscenza” intesa in senso oggettivo. E inoltre se vi sia identità quanto a modalità operative tra procedimenti di accertamento della verità tra diverse branche del sapere umano, e segnatamente tra quello scientifico-epistemologico, relativo al problema dei fondamenti e della portata del sapere scientifico, e quello umanistico-gnoseologico, relativo ai diversi livelli di astrazione e ai gradi di conoscenza della realtà. Altro e conseguente problema è poi capire dove, nell’ambito di queste due distinte branche, si collochi quella particolare tipologia di sapere costituito dal sapere giudiziario, ovvero quel sapere inferenziale che viene sperimentato ogni giorno negli uffici giudiziari e nelle aule di giustizia.
Entrambe le domande, dopo secoli di dibattiti scientifico-filosofici, hanno ricevuto una risposta chiara solo negli anni trenta del secolo scorso, con due risultati emersi uno in ambito fisico ed un altro in ambito matematico.
Nel 1927 il fisico tedesco Werner Karl Heisenberg, premio Nobel per la fisica nel 1932, uno dei padri della moderna fisica quantistica, elaborò e scoprì il cd.principio di indeterminazione, concetto che esprime il limite fondamentale nella capacità di studiare un sistema fisico in quanto osservare e misurare implica un perturbamento del sistema osservato. Secondo questo principio la posizione di una particella osservata viene cioè condizionata dall’osservatore che entra così in una strettissima relazione con l’oggetto della osservazione, in guisa da influire sulla sua posizione, velocità, etc. attraverso il fascio di luce che occorre all’osservatore per osservare. Ma ciò comporterà una modifica di posizione e velocità della particella osservata: da qui l’ineliminabile indeterminazione della misurazione in termini di certezza, ma solo di estrema probabilità, delle grandezze che riguardano la particella.
Pochi anni dopo, nel 1931, venne presentata la cd. “Prova di Godel” , attraverso cui è stata dimostrata l’esistenza in ambito aritmetico di proposizioni formalmente indecidibili, cioè tali che, pur essendo vere, non sono inferenzialmente deducibili da un qualsivoglia insieme di assiomi: da ciò può desumersi che le proposizioni dimostrabili sono in numero inferiore rispetto a quelle vere, ovvero che l’uomo riconosce come vere un numero maggiore di proposizioni date rispetto a quanto possa poi dimostrare.
Entrambe queste scoperte stanno a significare che anche in ambito scientifico-matematico, e non solo in ambito umanistico, l’osservatore interagisce con ciò che è osservato, costituendo un tutt’uno con l’oggetto della ricerca, e quindi il suo approccio determinerà delle conseguenze su ciò che si osserva e ricerca. E d’altra parte, non solo in ambito umanistico vi sono proposizioni indimostrabili in termini di certezza.
Ciò premesso, possiamo dire che la ricerca della verità giudiziaria non si distacca dalle caratteristiche delle osservazioni scientifiche ed umanistiche in cui si svolge un ragionamento inferenziale che partendo da alcuni elementi noti, attraverso un ragionamento induttivo, deve risalire a dati ignoti, ponendosi esattamente a metà strada tra i due diversi ambiti, e svolgendo quasi una sorta di disciplina-ponte tra i due macrosistemi.
Quanto in ciò influisca la personalità del ricercatore, è evidente. Una ricerca svolta allo scopo di individuare il responsabile ignoto di una data azione costituente illecito penale porterà a risultati diversi a seconda se il ricercatore svolgerà i suoi compiti con maggiore o minore professionalità, se si proponga di raggiungere una verità che egli già ipotizza in base a determinate, giuste o sbagliate, convinzioni, o se si lasci guidare dagli elementi che via via acquisisce, o ancora se cercherà elementi a riscontro solo nella direzione dal suo approccio auspicata o se invece cercherà elementi in grado di falsificare la proposizione elaborata.
Dice Luigi Ferrajoli: (Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza– Contro la giurisprudenza creativa, in Questione Giustizia, 4/2016) “ Ogni applicazione della legge richiede dunque una decisione e perciò un’argomentazione a sostegno della scelta tra le tante, possibili interpretazioni legittimamente ammissibili degli enunciati normativi. Si tratta però di decisioni sulla verità, e non su altri valori, cioè di decisioni le cui motivazioni sono argomentate come “vere” o confutate come “false” sulla base del diritto vigente. È in questa decisione sulla verità che risiede il nesso ineludibile della giurisdizione con la legalità e la differenza – strutturale, qualitativa, sostanziale – tra legislazione e giurisdizione, tra argomentazione legislativa e argomentazione giudiziaria, tra creazione del diritto e sua interpretazione e applicazione. La differenza è resa evidente dai diversi tipi di argomentazione che si richiedono a loro sostegno: le argomentazioni a sostegno delle decisioni giurisdizionali, essendo decisioni sulla verità, avvengono sulla base di prove e di qualificazioni normative del fatto provato; le argomentazioni a sostegno delle decisioni politiche, siano esse legislative o di governo, sono invece decisioni su altri valori: l’interesse generale, l’utilità, l’opportunità, la giustizia e simili. Le sentenze sono infatti gli unici atti giuridici la cui validità e ancor prima la cui giustizia dipendono dalla (accettazione come) “verità” delle loro motivazioni. La cosa è evidente nella giurisdizione penale: diciamo che una sentenza penale è valida, e prima ancora che è giusta, se le imputazioni accusatorie, per esempio l’accusa di omicidio, sono (argomentate come) “vere”, in fatto e in diritto; diciamo che è invalida e riformabile, e prima ancora che è ingiusta, se queste medesime ipotesi sono “false” (o comunque non argomentate come vere). Ma la stessa cosa può dirsi di qualunque sentenza, la cui validità e la cui giustizia dipendono dalle plausibili argomentazioni come “vere” delle sue motivazioni, sia fattuali che giuridiche. Qualunque sentenza di merito esibisce perciò la forma del tanto vituperato sillogismo giudiziario”. Risulta pertanto fondamentale che il ragionamento giudiziario che ha per oggetto la verità dei risultati probatori venga acquisito col metodo giusto e non con metodi che solo in modo illusorio ci avvicinano alla verità.
Questi metodi illusori risultano tali in quanto conducono a risultati falsi, potenzialmente inficiati da due fattori, entrambi esiziali per il risultato: l’errore e/o l’inganno, che spesso conducono a “verità” connotate da incompletezza. “Molte delle tesi più fuorvianti e ingannevoli presentate nella sfera pubblica hanno un qualche barlume di verità: ed è precisamente quel pallido accenno a deciderne la credibilità e l’ostinato ripresentarsi” (cfr. F. D’Agostini, M. Ferrera, cit., pag. 30). Verità parziali, “mezze verità”, e in quanto tali, estremamente dannose per il discorso pubblico in quanto inidonee a fondare giudizi affidabili.
Tuttavia, non è solo in ambito giudiziario che si richiede la corrispondenza dei giudizi alla realtà: la “felicità pubblica”, come concetto che comprende il benessere e la pace sociale, si nutre profondamente del bene-verità. “La psicoanalisi, la psichiatria, la psicologia sociale hanno evidenziato i danni che la mancanza di verità può produrre al benessere psichico degli individui” (cfr. F. D’Agostini, M. Ferrera, cit., pag. 28).
2.Il nemico interno: il metodo (errato) della verificazione.
Sotto il profilo del metodo, non v’è dubbio che la migliore modalità per acquisire risultati probatori tendenzialmente corretti ed in grado di far giungere il ricercatore ad un grado di conoscenza più elevato e nello stesso tempo più affidabile è quello elaborato dal filosofo ed epistemologo austriaco Karl Popper, coetaneo e contemporaneo di Heisenberg, il quale nell’elaborazione della sua teoria gnoseologica del “Razionalismo critico”, sosteneva il rifiuto dell’induzione come metodo scientifico basato sulla verificazione, adottando l’opposto principio della falsificazione come criterio di demarcazione tra scienza e non scienza. Egli sosteneva che “ogni qualvolta una teoria sembra essere l’unica possibile, va presa come un segno che non si è capito né la teoria, né il problema che si intendeva risolvere”. In sostanza di fronte ad una proposizione che risolve un problema gnoseologico, non andrebbero cercati elementi che ne confermano l’inferenza e la validità, che possono condurre a risultati fallaci, ma argomenti che ne falsifichino la validità attraverso un sistema di congetrture e confutazioni successive. Solo il superamento delle confutazioni consentirebbe, secondo questa teoria, al raggiungimento di un grado superiore di conoscenza nell’ambito osservato. Applicando tale ragionamento nell’ambito giudiziario, la teoria per congetture e confutazioni è quella che appare sviluppare meglio il relativismo della conoscenza giudiziaria secondo il principio, ormai costituzionalizzato, dell’oltre il ragionevole dubbio. Secondo Popper, come anche secondo Heisenberg, ciascuno secondo il proprio ambito epistemologico, l’osservazione non è mai neutra, ma è sempre intrisa di teoria, tanto da risultare difficile, se non impossibile, distinguere i fatti dalle opinioni. Ciò è dovuto alla inconscia tendenza umana a sovrapporre i proprio schemi mentali e le proprie sovrastrutture culturali alla realtà osservata. “La base empirica delle scienze oggettive – soleva dire Popper– non ha in se nulla di assoluto. La scienza non poggia su uno strato di solida roccia, bensi è come un edificio costruito su palafitte”.
Popper propone quindi di distinguere due diversi atteggiamenti dell’uomo: 1.l’atteggiamento dogmatico, naturale nell’uomo e utile alla costruzione delle teorie (e alla loro difesa contro apparenti confutazioni o piccoli errori della teoria, che va quindi solo modificata): è proprio di chi ha credenze forti, di chi vede regolarità anche dove non ve ne sono; 2. l’atteggiamento critico, proprio di chi è disponibile a modificare le proprie convinzioni. L’atteggiamento corretto dello scienziato, così come quello del giudice o del pubblico ministero in ambito giudiziario è ovviamente il secondo, in quanto caratterizzato da assenza di pregiudizio e volontà di raggiungere il risultato “vero”, senza obiettivi precostituiti. Ma quello dogmatico, in realtà è semplicemente pre-scientifico, nel senso che è più antico: “l’atteggiamento critico, infatti, non è tanto opposto a quello dogmatico, quanto sovrapposto ad esso: la critica deve essere diretta contro credenze esistenti e influenti, bisognose di revisione critica – in altre parole contro le credenze dogmatiche.” La credenze dogmatiche sono quindi la “materia prima” dell’atteggiamento critico. Nella scienza quindi le teorie non vengono trasmesse come dogmi, ma “piuttosto con la sfida a discuterle e migliorarle”. E’ la grande scoperta dei Greci, dei primi filosofi. Naturalmente la logica ha un’importanza notevole per l’atteggiamento critico, perché i punti deboli di una teoria “si trovano generalmente solo nelle conseguenze logiche più remote che se ne possono derivare”. E’ dunque maggiormente razionale il procedimento per congetture e confutazioni (tentativi ed errori) perché la nostra accettazione delle congetture è sempre provvisoria: non abbiamo di meglio, al momento. E “neppure c’è alcunché di irrazionale nel fare affidamento, a scopi pratici, su teorie ben controllate, giacché non ci è consentita nessuna condotta più razionale (…) del procedimento per congetture e confutazioni, che consiste: nell’audace formulazione di teorie; nel tentativo di mostrare che tali teorie sono erronee; nella loro provvisoria accettazione se i nostri sforzi critici non hanno successo.”
Quindi, il primo avversario della verità è il metodo che si utilizza per cercarla. Un metodo teso a cercare conferme non consente di pervenire a risultati utili come invece l’uso di un metodo che cerca di falsificare e di confutare la tesi di partenza al fine di sgombrare il campo di osservazione da ipotesi false.
3.Il nemico esterno: il segreto.
Ma c’è un altro avversario della verità, molto più mutevole, insidioso e dannoso per la collettività, fino a poter corrodere dall’interno la democrazia stessa: il segreto quale metodo utilizzato dal Potere (soprattutto quando esso faccia riferimento allo Stato o a strutture ad esso riferibili) per nascondere ai cittadini vicende che riguardano fatti di rilievo pubblico o addirittura per commettere reati in nome della sicurezza o di un malinteso concetto di difesa dello Stato. Si tratta di temi che hanno inspirato sin dagli anni ’70 del secolo scorso letteratura e cinematografia, basti pensare a pellicole come “I tre giorni del condor” di S. Pollack, o “L’Amerikano” di Costa-Gavras, o ancora “Good bye & amen – l’uomo della CIA” di D. Damiani fino a, ancora più significativamente, “Segreto di Stato” di G. Ferrara.
Il segreto si pone in tale contesto come cifra simbolica del cd. “potere invisibile”, quello che richiama l’esistenza di strutture statali o antistatali segrete e che fece dire a N. Bobbio, all’indomani della strage di Piazza Fontana a Milano, che “l’unico modo per vincere la violenza è quella di riconoscerla anche quando non scende e grida in piazza ma si nasconde dietro la decorosa facciata delle istituzioni che difendiamo” (cfr. N. Bobbio, La violenza di Stato, in “Resistenza” XXIV, gennaio 1970). E’ da allora infatti, che fanno la loro comparsa sulla scena mediatica nazionale concetti come “servizi deviati”, “poteri occulti”, “corpi separati”, “depistaggi”, “strutture parallele” con i quali continueremo nei decenni successivi a confrontarci purtroppo spesso, dalle vicende più drammatiche della nostra storia (dalle stragi di terrorismo e mafia a Ustica) a quelle meno drammatiche ma non meno inquietanti dei giorni nostri (come le riunioni segrete per decidere o condizionare le nomine di vertici di alcuni importanti uffici giudiziari da parte di parlamentari e magistrati al di fuori delle dinamiche del CSM).
Il filo che lega queste vicende, pur così diverse, tra loro è solo uno: l’uso del segreto come sistema per impedire alla collettività di formarsi una opinione limpida su dati fatti o sull’operato delle istituzioni statali in generale e/o sulla connivenza delle stesse con poteri occulti illegali. Il tema molto in voga sin dagli anni ’70 del secolo scorso, si spinge sino all’attualità passando da tutti i misteri italiani (stragismo fascista, Ustica, Gladio, stragi di mafia del 92/93, la trattativa Stato-mafia, etc.) rimonta in definitiva ad una problematica strutturale connessa sia ai regimi democratici, sia ai regimi totalitari, ed è quella del cd. “Doppio Stato”, dal titolo del fondamentale saggio di Ernst Fraenkel (“Der Doppelstaat”, Frankfurt am Main, 1974; trad. it. “Il doppio Stato. Contributo alla teoria della dittatura” Einaudi, 1974) che prendeva in esame negli anni ’30 del ‘900 le modalità operative dei tribunali tedeschi sotto il Terzo Reich, laddove ciò che avevano deciso i tribunali applicando le norme di diritto ancora formalmente in vigore, poteva essere rovesciato con decreti ad hoc del ministero degli interni o di altri organi dell’Esecutivo, se la decisione non era conforme agli interessi politici della Nazione. In tal guisa alle strutture giuridiche dello Stato di diritto, ancora formalmente in vigore durante il nazismo, operante secondo criteri normativi di necessità, si affiancava e si sovrapponeva uno Stato discrezionale, operante secondo criteri di mera opportunità. In sostanza, uno “Stato di eccezione” permanente, in grado, a seconda delle situazioni, di soppiantare le regole giuridiche dello Stato di diritto. Secondo Bobbio in tutti i paesi, sia in quelli democratici sia in quelli autoritari, esiste un “doppio stato”: la differenza consisterebbe nel livello di segretezza del doppio livello, che nei paesi retti da regimi dittatoriali è sostanzialmente nullo perché lo stato discrezionale è connaturato ai regimi dittatoriali e ne costituisce la cifra simbolica, mentre nei paesi democratici lo Stato discrezionale che opera secondo criteri di opportunità politica si tenta di tenerlo occulto e celato alle masse, parlandosi appunto di “potere invisibile”. Quando viene per un qualche motivo qualunque scoperto, si grida allo “scandalo”. Si pensi alla vicenda “Watergate” che spinse negli USA il Presidente Nixon alle dimissioni, una volta scoperto lo spionaggio sistematico operato dal Governo ai danni degli avversari del partito democratico, allo scandalo dei petroli in Italia nel 1973, o ancora le ultimissime vicende delle nomine del CSM pilotate dalla politica durante incontri clandestini, scoperti solo grazie ad alcune intercettazioni telefoniche.
Nelle riflessioni di Bobbio sul “potere invisibile” dei primi anni ’80 del secolo scorso (N.Bobbio, “Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco”, Einaudi 1984) si evidenzia a chiare lettere come sia incompatibile con un regime autenticamente democratica l’esistenza anche solo episodica di uno Stato discrezionale sotterraneo ed invisibile che si intrometta nelle dinamiche democratiche, tanto da fargli dire che la democrazia “è il governo del potere pubblico in pubblico”, ovvero fuori da logiche occulte e da dinamiche che non siano ostensibili al pubblico per timore dello scandalo, la cui azione deve essere quindi “palese e manifesta” in contrapposizione proprio alla segretezza delle pratiche governative che rispondono non a norme giuridiche ma a criteri di opportunità politica occulta. Quanto queste dinamiche possano incidere sul terreno della lotta per l’affermazione dello Stato di diritto anche all’interno di uno stato democratico, basti pensare alla vicenda del sequestro di Abu Omar, spiegata in termini molto chiari da Armando Spataro (A.Spataro, Ne valeva la pena, Laterza, 2010).
Abu Omar è un imam molto seguito a Milano e in Lombardia agli inizi del 2000. Sospettato di essere collegato ad ambienti terroristici, e per questo indagato e sottoposto ad intercettazioni telefoniche, il 17 febbraio 2003 scompare, ed immediatamente gli inquirenti ipotizzano un sequestro di persona ad opera di Cia o servizi segreti egiziani. La Procura di Milano all’esito di complesse e doviziose indagini, chiedeva il rinvio a giudizio per sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Abu Omar di ventisei cittadini americani, tutti appartenenti alla CIA, a vario titolo coinvolti nel sequestro, e di cinque cittadini italiani appartenenti al SISMI, il servizio segreto militare italiano, tra cui il direttore generale Pollari. Nel corso dell’udienza preliminare faceva capolino per la prima volta la questione del segreto di Stato, in quanto la difesa del generale Pollari sosteneva che il suo assistito non si poteva difendere in quanto costretto al silenzio dalla presenza, sui fatti in esame, del detto segreto. La volontà del GUP di andare avanti nel processo determinava il 14.2.2007 il primo conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidenza Prodi) contro la Procura di Milano innanzi alla Corte Costituzionale. Il 16.2.2007 il GUP disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, e il 7.3.2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (sempre Prodi) decideva di sollevare il conflitto di attribuzioni anche contro il GUP. I conflitti riguardavano più aspetti dell’indagine, tutte confliggenti con una presunta normativa sul segreto di Stato.
In primo luogo le intercettazioni disposte avrebbero comportato il disvelamento di 85 agenti del SISMI e delle strutture di riferimento: tali intercettazioni sarebbero illegali perché in violazione con il segreto di Stato; in secondo luogo sarebbero state svolte pressioni dai P.M. nei confronti di indagati inducendoli a violare il segreto di Stato (con ciò, evidentemente, attribuendo anche la commissione di reati ai P.M. procedenti); in terzo luogo sarebbero stati utilizzati documenti del SISMI coperti da segreto di Stato. Le medesime violazione sarebbero state poste in essere dal GUP nell’utilizzazione di quelle fonti di prova coperte da segreto. Ebbene, agli atti del processo non vi era alcun atto coperto da segreto di Stato, e solo in data 3.8.2007, a vicenda Abu Omar in pieno svolgimento, sarebbe stata portata avanti in tempi brevissimi una riforma dei servizi segreti che consentiva ai suoi aderenti di non rispondere, testi o indagati, a domande dell’A.G. vertenti su circostanze coperte da segreto di Stato. Stranamente, ma non tanto, le nuove norme consentivano ciò che il giudice aveva negato ai difensori di Pollari, ovvero avvalersi della facoltà di non rispondere per l’incidenza del segreto di Stato.
In un’ottica bipartisan, a rivelare quanto il Potere invisibile faccia quadrato quando minacciato di essere svelato dai poteri visibili, nel 2008, caduto il governo Prodi, il nuovo governo Berlusconi ribadiva il conflitto allargandolo anche al giudice del dibattimento, davanti al quale ormai si svolgeva il processo.
In questa sede non è possibile ripercorrere le vicende del processo per il sequestro di Abu Omar e quelle, collaterali, degli ostacoli frapposti dallo Stato-Governo alla ricerca della verità cui procedeva lo Stato-Magistratura. Si rimanda al resoconto completo ed emozionante svolto da Armando Spataro nel suo libro di memorie sopra ricordato. Va solo qui detto, in estrema sintesi, che l’11 marzo 2009, con la sentenza n. 106, la Corte Costituzionale in sostanza esclude sia il controllo giurisdizionale ordinario sul potere di secretazione del Governo, sia il controllo di costituzionalità attraverso i suoi poteri di controllo, e stabilisce che la motivazione dell’atto di secretazione va confinato sul terreno dei rapporti politici, con ciò sottraendolo a qualunque controllo, ed evocando il concetto di “stato di eccezione e decisione sovrana”, secondo gli schemi esposti negli sin dagli anni ’20 del secolo scorso da Carl Schmitt nella sua Politische Theologie. Un salto indietro di circa 100 anni! Per altro la decisione della Corte appare deludente soprattutto per non aver accolto la tesi della Procura di Milano, esposta dal prof. Alessandro Pace, di considerare il sequestro di Abu Omar come rientrante tra i fatti eversivi dell’ordine costituzionale e in quanto tale non suscettibili dell’opposizione del segreto di Stato, e ciò dopo aver dato atto della assoluta illiceità delle cd.”extraordinary renditions”, nel cui ambito rientrava in modo solare l’operazione Abu Omar. Una specie di equilibrismo giuridico per tenere insieme il giudizio di illegalità delle “renditions” e il trincerarsi dietro il segreto di Stato per impedire l’accertamento della verità e l’individuazione e punizione dei responsabili. Dice infatti la Corte, che “un singolo atto delittuoso, per quanto grave, non è di per sé suscettibile di integrare un fatto eversivo dell’ordine costituzionale, se non è idoneo a sovvertire, disarticolandolo, l’assetto complessivo delle istituzioni democratiche” (cfr. A.Spataro, cit., pag. 541). Il 4 novembre 2009, dopo la discussione delle parti, il giudice del dibattimento pronunciava la sentenza che ne costituiva la chiusura, condannando gli imputati agenti della CIA, che non erano mai stati arrestati, in quanto mai il Governo italiano aveva inoltrato i necessari atti, mentre gli imputati italiani, tra cui il generale Pollari, che si erano avvalsi del segreto di Stato, affermando di non potersi difendere a causa di tale imposizione governativa, erano prosciolti.
Quale vulnus sia stato inferto al diritto e alla Costituzione sia ad opera del Governo italiano (va detto, in modo assolutamente bipartisan) sia – spiace dirlo- della Corte Costituzionale, ovvero di organi la cui vocazione istituzionale è il rispetto della legge e della Costituzione, è di tutta evidenza e segnalato dai massimi esperti di diritto costituzionale (per una ampia sintesi, cfr. in appendice, par. 18, A.Spataro, cit., pag. 594).
In conclusione di queste brevi e superficiali note possono essere ricordate le parole, del giudice della corte Suprema americana Sandra Day O’ Connor citate da A. Spataro (A. Spataro, cit., pag. 562) nella sua requisitoria innanzi al giudice del dibattimento del tribunale di Milano: “Le democrazie si fondano su principi irrinunciabili anche nei momenti di emergenza e finanche dopo aver subito tragiche aggressioni (…) eppure governi che così frequentemente declamano la loro adesione a tali principi si scoprono poi, nella prassi, spesso insensibili al loro rispetto. Ma la lotta al terrorismo internazionale, in tal modo sarebbe persa in partenza,. Noi non abbiamo alternativa al rispetto assoluto della legge, anche dove e quando ciò sembra difficile. Solo questo ci da credibilità e speranza”.
In realtà, vicende come quella accennata legata al sequestro di Abu Omar ed alle iniziative politiche conseguenti alle indagini della Procura della Repubblica di Milano, (ma anche altre, come la chiusura dei porti alle navi che effettuano il salvataggio dei migranti in mare, o ancora le norme amministrative disponenti l’immunità penale per l’ex ILVA, tutte afferenti a introdurre registri giuridici differenziati rispetto alla generalità dei cittadini) danno l’esatta dimensione di quanto sia presente e prossimo alle nostre vite (se non logiche da “doppio Stato”), il cd. “Stato di eccezione”, ovvero lo svuotamento, attraverso atti politici, dello Stato di diritto regolato da leggi e Costituzioni, e come lo Stato di diritto funzioni fintantoché ciò non confligga con il diverso avviso del potere Esecutivo, vero centro propulsore dell’auctoritas statale, il quale si muove ormai solo secondo piena discrezionalità politica. Si può pertanto convenire con chi sostiene, realisticamente, che “Lo stato di eccezione ha anzi raggiunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando all’esterno il diritto internazionale e producendo, all’interno, uno stato di eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto.” (cfr. G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003).
Questa tendenza degli organismi statali appare inarrestabile da circa un secolo a questa parte. Agamben parte dalla normativa via via emanata dagli U.S.A. dopo l’11 settembre, tesa ad introdurre uno stato di eccezione permanente sia all’interno che all’esterno del paese, in sfregio sia al diritto internazionale sia alla normativa costituzionale interna (in base alla giustificazione, in verità piuttosto puerile, che ciò che accadeva a Guantanamo era in un territorio non facente parte degli Stati Uniti d’America, nei confronti di non-cittadini, e quindi sottratto a quelle garanzie), e ad imporre per via legale l’esercizio arbitrario di una pura violenza che si vuole schmittianamente “detentrice di un nuovo nomos della terra”: un ordine mondiale da imporre globalmente a colpi di guerre umanitarie e/o preventive, attraverso le quali realizzare una costituzione imperiale capace di imporsi al termine della cosiddetta guerra civile mondiale, declinata secondo le retoriche manichee del conflitto di civiltà. Al tempo stesso, sul piano interno, lo stato di eccezione è restituito dalla progressiva trasformazione involutiva dei codici penali e di quelli di procedura penale nel cuore dell’occidente. Con la normalizzazione della Indefinite Detention, e poi con le cd. extraordinary renditions, si è giunti a privare di ogni status giuridico qualunque individuo non cittadino, sospetto di essere in qualche modo coinvolto in attività terroristiche. Citando Judith Butler, Agamben osserva che i detenuti di Guantanamo, giuridicamente innominabili e inclassificabili, sono “oggetto di una pura signoria di fatto” (p. 13). Viene così a realizzarsi quella che Walter Benjamin chiamava la “nuda vita”, priva di rilievo giuridico, la quale raggiunge la sua massima indeterminazione proprio con le Indefinite Detention, prive di tempi, difesa e finanche di capo d’accusa, e poi con le cd. extraordinary renditions, sequestri di persona effettuati con il concorso di servizi segreti nazionali e con la copertura del segreto di Stato che ne impedisce di fatto l’accertamento sotto il profilo puramente penalistico.
Dal punto di vista teorico lo stato di eccezione è dunque quella figura dell’ordine sospeso e continuamente infranto in cui “l’aspetto normativo è impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale” che ignora, all’esterno, il diritto internazionale e produce, all’interno, uno stato di emergenza permanente. E tuttavia, pur generando “uno spazio vuoto di diritto”, lo stato di eccezione accampa con arroganza la pretesa di “stare ancora applicando il diritto” (p. 111). Al suo interno, l’esercizio della pura violenza sganciata dal diritto impone la fictio juris secondo cui a produrre ordine sarebbe pur sempre la legge. Lo stato di eccezione si presenta quindi come “la forma legale di ciò che non può avere forma legale”, in cui l’eccezione sovrana agisce come dispositivo biopolitico mediante il quale il diritto “include in sé il vivente attraverso la sua propria sospensione”: proprio come nel Military Order del presidente Bush (p. 52).
Ciò che ci spetta, come giuristi nello specifico, o come cittadini in genere, è cercare di s-velare l’artificiosità delle costruzioni pseudo-giuridiche che tentano di e tendono a coprire col paludamento del diritto ciò che giuridico non è, in quanto decisione politica discrezionale in termini di mera opportunità. Tale prassi, ormai sdoganata anche nel nostro ordinamento, nega l’essenza della norma giuridica pur facendo ad essa riferimento fittizio con argomentazioni capziose e contraddittorie. Che ci sia lasciata, tuttavia, la libertà di sottolineare i vulnera ai diritti costituzionali, nel tentativo, in ossequio al più profondo dovere giuridico, etico e scientifico, di rispondere alla domanda di Pilato con cui abbiamo iniziato la riflessione: “Quid est veritas?”